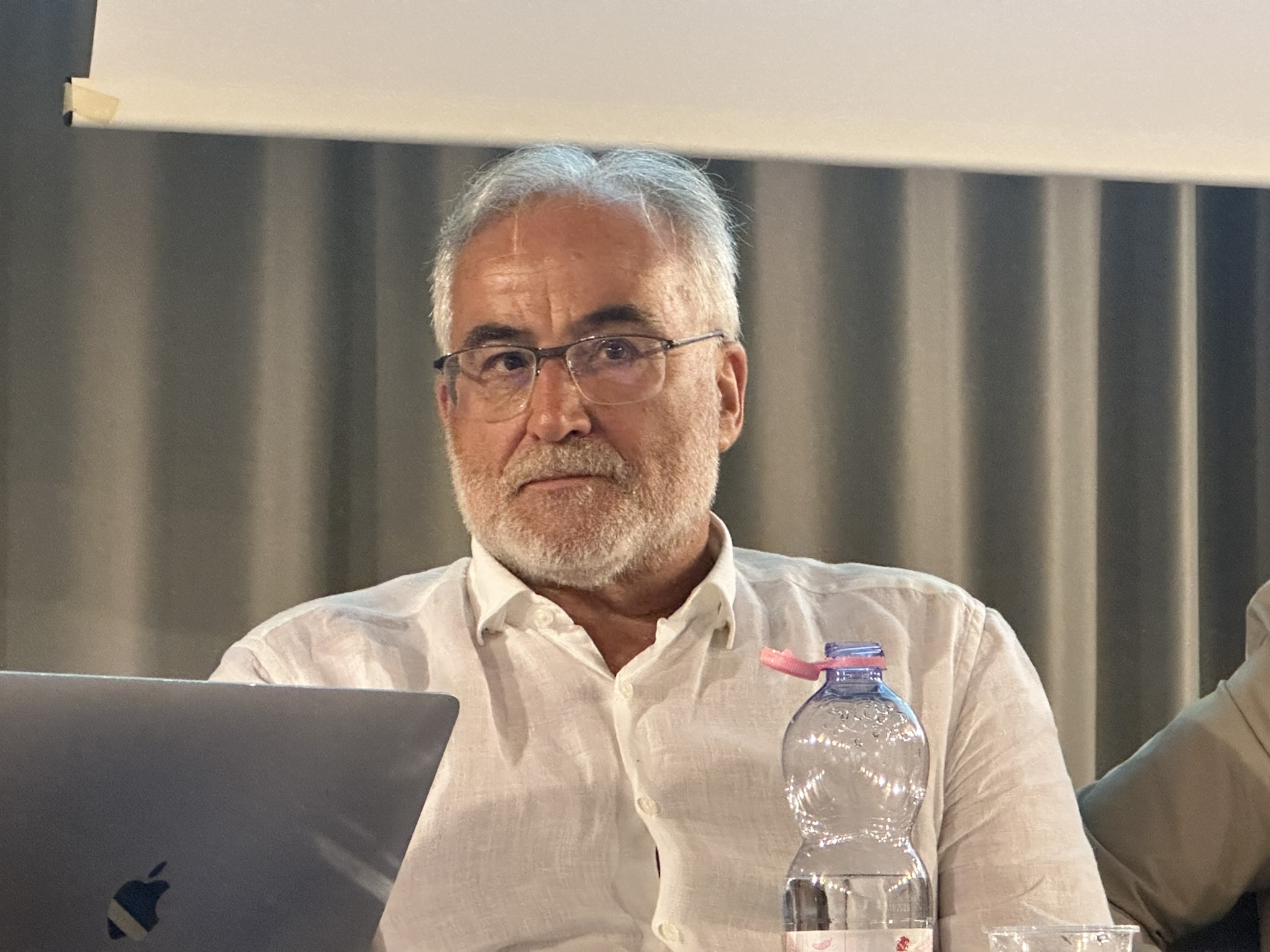Marino Fardelli Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane ha voluto rivolgere diverse domande a Javier Hernández García, già Lugarteniente del Justicia de Aragón (2018–2024) e Docente presso Universidad de la Experiencia de Zaragoza e protagonista in Spagna di un importante lavoro di prossimità e innovazione istituzionale nella tutela dei diritti.
Marino Fardelli Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome italiane ha voluto rivolgere diverse domande a Javier Hernández García, già Lugarteniente del Justicia de Aragón (2018–2024) e Docente presso Universidad de la Experiencia de Zaragoza e protagonista in Spagna di un importante lavoro di prossimità e innovazione istituzionale nella tutela dei diritti.
L’intervista nasce nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra le istituzioni italiane e spagnole per la promozione delle buone pratiche nel settore della difesa civica. Di seguito il testo integrale dell’intervista:
1. Quali sono, secondo lei, i tratti distintivi del modello aragonese di difesa civica rispetto ad altri sistemi regionali in Spagna o in Europa?
Il moderno Justicia de Aragón affonda le sue radici nel “Justicia” storico, di cui si hanno notizie sin dal 1115, nato come figura di difesa dei diritti dei cittadini contro il potere monarchico. Questa forte valenza identitaria è ancora oggi viva: ogni 20 dicembre, giorno del Justicia, si celebra a Saragozza una grande offerta floreale pubblica.
L’attuale istituzione, sancita dallo Statuto di Autonomia del 1982, non è un semplice commissario parlamentare ma una delle istituzioni fondamentali di autogoverno della Comunità autonoma, con rango di terza autorità. Inoltre, il Justicia è anche tutore del diritto aragonese, in particolare del diritto civile, distinto in molti aspetti dal Codice civile spagnolo.
2. Durante il suo mandato ha osservato un cambiamento nella relazione tra cittadini e istituzioni?
Esistono due modelli legittimi di difesa civica: uno più “burocratico”, che gestisce le denunce secondo la legge, e uno più “proattivo”, che scende nel territorio, ascolta e cerca soluzioni anche non strettamente giuridiche. Io ho scelto questo secondo approccio: ho girato l’Aragona, dialogando con cittadini e autorità locali, facendo anche opera pedagogica con le amministrazioni.
3. Qual è il caso o l’iniziativa che considera più significativa del suo mandato?
Sicuramente la creazione dell’Osservatorio Aragonese della Solitudine (OAS), dedicato all’analisi e al sostegno delle persone anziane sole. Ma anche tanti piccoli successi: garantire il trasporto scolastico a due bambini in aree rurali, ottenere cure specialistiche per chi attendeva da mesi, semplificare pratiche amministrative complesse.
4. Come valuta oggi il ruolo del Difensore civico nel contesto delle democrazie europee, alla luce delle sfide della digitalizzazione e dell’accesso ai servizi pubblici?
Le pubbliche amministrazioni devono “guardare negli occhi i cittadini”. Se la digitalizzazione è essenziale, non si può dimenticare che l’accesso deve essere garantito a tutti. In Spagna è obbligo delle amministrazioni rendere accessibili i servizi: purtroppo, soprattutto dopo la pandemia, ciò non avviene sempre. Le difese civiche hanno molto da dire e fare su questo.
5. In che modo il modello aragonese può offrire spunti utili alla difesa civica italiana?
Oltre al rango istituzionale elevato, è centrale la presenza nei territori e la capacità di usare i media per dare visibilità ai problemi. Le nostre sedi sono in un palazzo storico di grande prestigio, che potrebbe scoraggiare i cittadini, ma la nostra attività itinerante e comunicativa li avvicina a noi. Una risoluzione resa pubblica diventa occasione di sensibilizzazione per molte amministrazioni.
6. Qual è stato il contributo più rilevante del Justicia de Aragón a favore dei soggetti più vulnerabili?
Il Justicia redige annualmente un rapporto su infanzia e adolescenza, visitando strutture pubbliche e dialogando con residenti e operatori. Lo stesso è avvenuto per residenze per anziani e centri per disabili. Inoltre, abbiamo lavorato per accompagnare la riforma del diritto civile aragonese sulla capacità giuridica, aiutando le persone e le famiglie a comprendere i cambiamenti introdotti dalla Convenzione ONU del 2006.
7. Che consiglio darebbe a un giovane interessato alla tutela dei diritti e alla mediazione civica?
Credere nel ruolo delle difese civiche, non vederle come uffici burocratici. La loro forza è nell’autorevolezza, che si costruisce con il rigore e la qualità del lavoro. Chi si avvicina a questo mondo deve avere una visione anche un po’ romantica: credere nei cittadini, nei loro diritti e nella possibilità di farli valere contro una burocrazia a volte opprimente.
8. Qual è la sua opinione sulla rete dei Difensori civici regionali e provinciali italiani?
Conosco bene la realtà italiana: ho instaurato legami di collaborazione e amicizia con i colleghi. Apprezzo la crescita del Coordinamento, che sta creando sinergie importanti. Non esiste un unico modello perfetto in Europa, ma è fondamentale che le difese civiche abbiano poteri chiari e strumenti efficaci, compresa la possibilità di sanzionare la mancata collaborazione. Lavorare in rete, anche a livello europeo, è la chiave per essere sempre più incisivi.